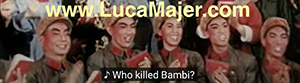LIVE! VISTI E SENTITI
LIVE! VISTI E SENTITI
 [nell'immagine: David Grubbs, foto di Ubaldo Manfroncelli]
[nell'immagine: David Grubbs, foto di Ubaldo Manfroncelli]David Grubbs
Istituto Polacco, Roma, 17 gennaio
David Grubbs, come dice Giuseppe Armogida di Flaming Creatures, che ha curato l’evento, è stato ed è per molti di noi un punto di riferimento. Capace di attraversare mondi diversi, percorrendo distanze apparentemente incolmabili, tra squat e università, ferocia post-hardcore e composizione contemporanea, improvvisazione e songwriting, memorie folk e astrazioni, ruggini rock, bagliori noise e tempeste avant. Un musicista enciclopedico e talentuoso, che ha fatto dell’eclettismo una cifra personale, pur restando sempre riconoscibile nella pronuncia, nella postura, nella voce, strumentale e non. Arguto e appassionato, ascoltatore a 360°, didatta, pensatore della musica e nella musica, torna in Italia in solo a presentare l’ultimo, ottimo “A Whistle From Above”, pubblicato quasi un anno fa da Drag City. Inizialmente il live segue proprio la scaletta dell’album, con la title track, un haiku strumentale che mette in mostra il classico armamentario grubbsiano che tanto ce lo ha fatto amare nel tempo e poi The Snake On Its Tail: armonie insinuanti, sghembe, un approccio alla forma canzone enigmatico, costruzioni sguscianti, ripide eppure accoglienti, sospese in un limbo fertile dove si incontrano mille istanze diverse, capaci però di coagularsi in forme coerenti e uniche. Antiche memorie folk filtrate attraverso lenti sporcate da fanghi noise, nebbie drone, brezze minimaliste, un approccio in generale aperto alla scrittura, costantemente in grado di tenersi lontano dalle secche della retorica e dalle paludi della didascalia, viaggiando da qualche parte tra ipnosi inquieta, sommessa elegia, lampi nitidi e quel senso di quieta remissione che era dna di certo post rock, di cui aveva detto il direttore anni fa. La peculiarità dei costrutti melodici, armonici, ritmici, sta nel loro essere articolati e complessi ma non complicati, felicemente cittadini di una terra di mezzo tra il narcolettico e il rivelatorio, abituati a poggiarsi sempre dove non te lo aspetteresti. John Fahey, Leo Brouwer, certe nevrosi che fanno intravedere nella penombra il profilo di Derek Bailey, arpeggi che potrebbero durare all’infinito, la chitarra come dispositivo d’ombre: c’è spazio anche per un momento che non è eccessivo definire commovente, quando intona The Season’s Reverse, dal capolavoro “Camoufleur” dei Gastr Del Sol. Una bella, bellissima canzone può reggere anche nuda, priva di arrangiamenti (su disco c’erano Rob Mazurek alla cornetta, Mark Popp, al secolo Oval, all’elettronica, John McEntire alla batteria, Steve Butters alla steel drum): ed è proprio il caso di questa specie di bossa nova psichica, indimenticata e indimenticabile. La seconda parte del set è più orientata verso la forma canzone classica, con molti frangenti cantati, a testimoniare i due principali poli di attrazione dell’arte del nostro, una sorta di compendio evoluto di Americana, tra fantasmi bluegrass che si mutano in drone in controluce, hillbilly raga, scorie di hardcore evoluto, echi di furia che persistono nelle aule di un’accademia libera e informale, il suono di una sveglia in un deserto noir, minime nevrosi ed epifanie urbane come un “Lost In Translation” per iniziati, sempre all’interno di un recinto di tensioni trattenute che non esplodono quasi mai, lasciando nelle orecchie il miele di una tensione perenne che cova come fuoco sottile sotto la cenere, e non accenna a spegnersi. Ed è anche per questo che su e con David Grubbs continueremo il discorso nel numero di febbraio della rivista. Nazim Comunale
Zu
Tpo, Bologna, 10 gennaio
Prima uscita pubblica in continente per gli Zu, dopo un’anteprima sarda, a presentare il nuovo “Ferrum Sidereum”, uscito il 9 gennaio su House Of Mythology: il disco testimonia un’inattesa metamorfosi della band, che pare aver trovato una quadra all’interno di un perimetro in parte inedito. Mai Zu (con il nuovo Paolo Mongardi alla batteria in ottima evidenza e il massiccio e funzionale innesto di synth) avevano suonato così psichedelici e prog, né così armonicamente articolati. Preceduti dalla performance affilatissima, ansiogena e perfettamente consonante coi tempi “Il Terzo Reich” di Claudio Castellucci (con il quale la band ha collaborato in passato), Massimo Pupillo (basso elettrico), Luca T. Mai (sax baritono e synth) e Paolo Mongardi (decisamente il batterista definitivo, dopo i tentativi più o meno a fuoco con altri, a seguito dell’uscita di Jacopo Battaglia) attaccano proprio dove comincia l’album, con i colpi di machete nella selva di Charagma, un macigno post-metal venato di sfumature ritualistiche; i synth entrano prepotentemente nelle spirali di Golgotha, mentre Kether suona sorprendemente simile ai migliori Tool, con uno sviluppo molto ben congegnato e travolgente, in particolare dopo un inciso dalle fragranze dub. La band è tirata a lucido, il meccanismo è oliato alla perfezione, la sala è sold out, tutto procede nel migliore dei modi, peccato solo per qualche sparuto coglione che si arroga il diritto di fumare sigarette rendendo l’aria poco respirabile a chi vuole godersi il concerto in modalità immersiva, non rifugiandosi nelle retrovie. Se alcuni brani fanno pensare agli Zu più familiari, quelli con la mannaia in mano a macinare unisoni e scomposizioni ritmiche (A.I. Hive Mind), sono il mood complessivo e la pronuncia che paiono aver compiuto una virata verso accenti più spirituali, più cosmici, finendo per suonare, anche se musicalmente siamo altrove, come dei Gong che sono caduti in un pentolone Napalm Death o dei Pink Floyd in fissa col thrash metal evoluto. Nella mistura di questa pipa ci sono tabacchi che provengono da piantagioni lontane, la ruggine di questi suoni titanici, prometeici è figlia di nuvole che abitano cieli tra i più diversi: l’industrial, il folk apocalittico, la dark ambient, una psichedelia che tende all’epos, narrative prog, il metal, un certo gusto tribale accentuato dall’uso delle percussioni di Mongardi, caverne psichiche dove inseguire ombre drone, ritual, per una celebrazione massimalista di forze che trascendono ogni parola, al netto di qualche prolissità dovuta comunque a un’ispirazione intensa, palpabile, a un bisogno di dire che esonda. Quando ho avuto modo di parlare con la band a proposito dell’album nuovo m'hanno parlato di una visita dell’ispirazione in fase di ideazione, composizione e registrazione e questa verità e urgenza si avvertono anche dal vivo. Ammirevole da parte del trio la capacità di reinventarsi e dare nuova linfa a un suono che poteva essere giunto a un capolinea; del jazzcore che c’era in passato, ammesso e non concesso che ci fosse, è rimasto poco (niente se non l’andamento fast &furious che però a tratti assume anche bradicardiche movenze doom); la band ora suona, quanto meno come attitudine, simile a esperienze esplorative del metal contemporaneo quali Sumac o Blood Incantation, devota alle proprie ossessioni e fedele alle proprie ombre: lirica, tesa, feroce e chirurgica. Confermando che il live è uno dei suoi storici punti di forza e ribadendo una statura internazionale, che avrà modo di mostrarsi in tutto il suo abissale, torrido nitore nel corso dell'ennesimo tour europeo. Per quanto ci riguarda assieme alla band avremo modo di compiere un altro viaggetto: ne saprete di più nel prossimo numero della rivista. Nazim Comunale
Moult Festival
Foligno, 5 gennaio 2026
Seconda edizione del Moult Festival a cura di Young Jazz. Dopo tre sessions del “Countdown” dedicate alla scena italiana con, tra gli altri, il batterista extra-ordinario Stefano Costanzo, del quale abbiamo scritto in un paio di occasioni sulla rivista, arriva una giornata di musica non stop, con la consulenza alla direzione artistica di Dan Kinzelman. Al secondo piano di Palazzo Candiotti si comincia con “Ea: one-voice study on a wordless dictionary” della cantante Nina Baietta. Un solo che si attesta da qualche parte tra Meredith Monk e Diamanda Galás: risvegli animali, versi di uccelli, un’indagine sulle origini, le radici della voce. Stimolante nella sua fragile, naturale imperfezione: un buon punto di partenza. Poi tocca al trio Witchess: Andrea Giordano (voce, flauto, elettronica), Silvia Cignoli (chitarra, elettronica e voce) e Francesca Remigi (batteria, percussioni, composizioni, voce) tra dichiarazioni politiche, ruggini avant, fratture timberniane, articolazioni prog, dilatazioni free form, diversi spunti non sempre gestiti al meglio, tra ombre canterburiane, fughe nel buio come dei Gong virati apocalisse, ansie Storm & Stress e costruzioni in opposition. La carne al fuoco è davvero tanta (troppa?), i materiali potrebbero far drizzare le orecchie ai tipi della Cuneiform; il disco di debutto, su Hora Records, è buono, il live in parte da calibrare: mood complessivo tra il narcolettico, l’onirico e il nevrotico: eclettico dunque ma non sempre equilibrato. Letteralmente straordinari invece gli svizzeri Sc’ööf, novità assoluta e sorpresa travolgente: Christian Zemp (chitarra, elettronica), Elio Amberg (sax alto, elettronica) e Vincent Glanzmann (batteria, laptop) conquistano il pubblico con un set bomba che fa tornare in mente memorie di Sinistri, primi Goat (quelli giapponesi), Kukan Gendai, gli Horse Lords caduti da un precipizio e ridotti male (quindi benissimo) oppure i conterranei Schnellertollermeier virati funk-core. Un concerto che trabocca energia in ogni minuto secondo: puntillismi, fibrillazioni, groove imprendibili, galaverna glitch, gelo artico. Immaginatevi questo, immaginatevi quello, ma la musica di questi tre giovanotti non ammette repliche: attacchi (di panico) al fulmicotone, clamorosi bruciori di stomaco, miracolose e controllatissime abrasioni free, a metà strada tra ansie indicibili e illuminazioni minimaliste. I tre distillano un liquore ad altissima gradazione che brucia le labbra e inebria lo spirito: nitidi bagliori noise, una controllata, selvatica follia jazzcore, la perfezione di un meccanismo rotto in mille pezzi. Cercateli su Bandcamp e dal vivo, saranno (sono già) grandi. Poco da dire sull’ultimo nome in scaletta, Gli I, ovvero Marco Bernacchia (elettronica) Andrea Davì (percussioni ed elettronica) e Manuel Scano (voce ed effetti): un’apparecchiata di chincagliere assortite che gioca la carta weird senza colpire nel segno. Moult si propone comunque come un festival da seguire, speriamo di poter tornare l’anno prossimo, quest’anno ne è valsa la pena. Nazim Comunale
Stereolab
Royal Festival Hall, Londra, 6 dicembre 2025
L’anno che sta per concludersi ha riservato due inaspettate e gradite sorprese: a pochi giorni di distanza dal ritorno sul palco dei My Bloody Valentine ecco l’altro gruppo britannico seminale che ha indelebilmente segnato gli anni novanta, gli Stereolab.
Intro di sequencer alla Kraftwerk, un paio di funerei accordi d’organo e parte lo space age pop retro futuristico di Aerial Troubles, con irresistibile, solido ye-ye groove da sculettamento, solare armonia vocale e maestosi riff di tastiera e chitarra. All’innodica Motoroller Scalatron, classico che paga omaggio ai Faust di J’ai mal aux dents, segue l’elegante Transmuted Matter, che conferma l’abile capacità di sovrapporre diverse tessiture sonore, e poi un tuffo nel passato col trascinante jingle jangle del classico Peng 33, dall’album d’esordio del 1992, sorretto da energetica sezione ritmica e synth lancinante, quindi l’euforia nostalgica del carosello futuristico di Flower Called Nowhere, rassicurante ninna nanna avant pop dalla morbidezza eterea, leggera, ariosa e delicata, soffice come lo zucchero filato, e ancora la malinconia barocca di Melodie Is A Wound, edificata ritmicamente su un’intuizione presa a prestito, forse inconsciamente, da Matto, caldo, soldi, morto girotondo del maestro Morricone, con la deliziosa seconda parte strumentale da sogno febbrile perfetta rappresentazione del suono stereolabesque, neologismo consacrato alla luce delle innumerevoli scopiazzature sentite in giro, che con rapidi cambi di tonalità ed accelerazioni ipercinetiche approda in un inaspettato finale electro-improv kosmische. È un’autentica fiera: l'allegra If I remember I forgot to dream dal ritmo vagamente jazzato anni venti, ideale per avventurarsi in movenze Charleston con bell’assolo di trombone di Laetitia e seconda parte bella dilatata; il superclassico Miss Modular col suo perfetto mix di lounge music ed electro- psych con la voce calda di Laetitia: abbagliati da tanta magnificenza, gli occhi diventano lucidi soprattutto per il ricordo della mai troppo rimpianta Mary Hansen, prematuramente scomparsa in circostanze tragiche, che col suo contributo vocale ha relegato questa canzone nell’olimpo dei classici atemporali. Alla space age bossa di Household Names seguono Esemplatic Creeping Eruption, che parte alla Harmonia/Cluster per poi diventare stereolabica con l’ospite Marie Merlet (sodale di Laetitia nel progetto Monade), Percolator con la sua vertiginosa sezione ritmica su cui si inerpicano i divertenti effetti del sintetizzatore, per terminare col galoppante motorik di Electroified Tennybop! per gli arpeggi frenetici dell’arp synth vocoder. L’encore, con l’ospite Marie nuovamente in scena, spetta agli accordi cosmic jazz di Immortal Hand, che dopo un passaggio electro funk minimale esplode nel suo splendore sinfonico, perfetta introduzione per l’elegante e raffinata Cybele’s Reverie che chiude le danze.
Certo, avessi stilato io la scaletta avrei inserito almeno John Cage Bubblegum e French Disko, ma con una discografia così ampia e di qualità sempre eccellente, la scelta è difficile e il tempo (sul palco) tiranno per cui nessuna lamentela, anzi. Bentornati Stereolab! Ferruccio Guglia
Darius Jones Trio
Jazz Club Ferrara, 6 dicembre
Occasione abbastanza rara, e dunque da non lasciarsi sfuggire, quella di veder Darius Jones in Italia, quindi dopo il live della settimana precedente di Ches Smith torniamo al Jazz Club di Ferrara, per il trio del sassofonista: delegazione blowuppiana formata dal sottoscritto e da Federico Savini, che intervistò il nostro dieci anni fa su Blow Up#202 in un articolo dove trovava spazio anche Matana Roberts. Se della musicista in altra sede ci è capitato di criticare in modo abbastanza netto la più recente esibizione live italiana, qui invece le iperboli si sprecano. Se la formazione, la medesima dell’ultimo, ottimo “Legend Of e’Boi” promette, con Jones all’alto, Chris Lightcap al contrabbasso e Gerald Cleaver alla batteria, il concerto mantiene: composizioni che talvolta paiono non avere un centro di gravità ben definito e in parte trovano forza proprio in questa natura ambigua, seducente, imprendibile, ma che in realtà svelano la propria assoluta solidità, data da una scrittura ispirata e sempre fuoco e benedetta da una sezione ritmica perfetta e da un interplay eccellente. Un vagare enigmatico tra ombre di fire music, swing cubista e sbilenco, negritudine a profusione, soul, elegia, lotta, cantabilità talora un po’ malmostosa ma sempre lirica e pungente. Il dettato e la pronuncia del leader spiccano per personalità e carisma: capita di sentire tracce che non capisci dove si appoggino, capaci di restare sempre coi piedi staccati da terra, macinando al tempo stesso groove inesorabilmente. La ritualità della musica ancestrale catapultata in scenari astratti, forme che appena si coagulano prendono altre strade, capaci di evaporare e farsi altro. Il mood è sempre interrogativo, in sottrazione, per un suono che pone domande più che dare risposte: le frasi intrise di free, di gospel, di blues del sax fioriscono sui muri mobili eretti da contrabbasso e batteria, capaci di aggiungere punteggiatura e di suonare sempre lievissimi e cruciali. Capita che Jones indugi su sovratoni e fischi, che Lightcap sfruculi le corde e la nostra anima, che Cleaver scuota noi assieme a pelli e tamburi e che il trio accarezzi il silenzio, per poi esplodere, senza risultare letteralmente mai prevedibile ma sempre maledettamente nitido, teso, ispirato, misterioso e avvolgente. Recuperate il disco se non lo avete sentito, è stata una delle vette in ambito jazz dell’anno passato; il live è stato uno dei più belli a cui abbiamo assistito nel 2025 e Darius Jones è uno dei musicisti jazz più importanti degli ultimi (parecchi) anni. Nazim Comunale
Ches Smith Clone Row
Jazz Club, Ferrara, 29 novembre 2025
In quello che è uno dei più bei locali (se non in assoluto il migliore) per ascoltare il jazz in Italia, al Torrione San Giovanni, arriva il nuovo progetto di Ches Smith, già ascoltato nella stessa sede con Snakeoil di Tim Berne nel 2017 e poi, tra le varie volte, anche con il trio di Marc Ribot Ceramic Dog sia a Strade Blu che al Lupo. Stavolta è il turno di un progetto dove il batterista di Sacramento è leader: Clone Row sono un quartetto che lo vede a elettronica, vibrafono, oltre che a piatti e tamburi, con la complicità di Nick Dunston al contrabbasso e doppia chitarra elettrica: Mary Halvorson e Liberty Elllman. Il quartetto presenta il disco uscito per Otherly Love a giugno di quest’anno. Basi di hip-hop dispari sghembo e serrato, tali da far pensare ad Anti Pop Consortium o Clipping e che fungono da fondamenta su cui imbastire incalzanti numeri di colta nevrosi urbana sporca di ruggine rock. Smith armeggia con un tablet e piccole diavolerie elettroniche, la sua batteria ha un pad e si muove con disinvoltura tra gli strumenti dettando il ritmo, in dialogo con l’ottimo Dunston alle quattro corde, mentre le due chitarre, affilata, acida ma un po’ algida quella di Halvorson, più selvatica e ispida quella di Ellman, dialogano aggiungendo spine alla rosa. Da vulcaniche geometrie esatte, astratte esplodono lapilli free; il clima è torrido e gelido al tempo stesso, electro avant jazz denso, convulso: costruzioni sguscianti, ansiogene, massimaliste, che esondano di suoni, di idee, di roba, che erompe dagli argini e si coagula in forme imprendibili ma che non sembra mai perdere di vista lo spartito, quantomeno come postura e forma mentis. Un suono che pare spesso sul punto di rompersi in mille pezzi ma che sa mantenere (forse fin troppo) sempre il filo del ragionamento, per quanto iper cerebrale, abitato da febbri anfetaminiche. Un flipper di istanze e influenze diverse, mille scomposizioni, eruzioni, controtempi e contrattempi, come uno swing da gaming giapponese allucinato, plurifratturato. Capita che il clima si quieti e si spalanchino porte che danno su altri giardini. Fanno capolino anche echi tribali, labirinti post tutto, fughe verso l’altrove. Per lunghi tratti lontano dalla batteria, Smith ha sempre polso disinvolto e sicuro nel guidare la nave, che conduce l’equipaggio in mezzo agli oceani perigliosi con maestria, ma pagando talora lo scotto di un’eccessiva freddezza, tra sequenze di obbligati, idee ripide e articolate che nella scrittura ricordano le salite erte di certo Berne ma tradiscono anche la fascinazione per un suono urban che permea un po’ tutte le tracce. Il meccanismo è oliato alla perfezione e più di un groove carezza l’estasi (Clone Row o la catatonia mobilissima di Sustained Nightmare), ma qualcosa (la composizione? L’intenzione? La nostra voglia di turbamento, forse?) ci lascia parzialmente distanti, fermo restando che parliamo di gente dal talento cristallino, di musicisti tra i più significativi nel panorama delle musiche creative e di un concerto molto divertente, il che non è davvero cosa di poco conto. Il programma del Jazz Club di Ferrara promette altre scintille per il 2026: intanto già in dicembre, tra le altre cose, ci saranno Darius Jones in trio (il 6) e i Tell Kujira il 19. Nazim Comunale
My Bloody Valentine
Ovo Arena Wembley, Londra, 25 novembre 2025
Con l’immancabile cappellino a visiera, J Mascis si presenta in versione acustica e per una quarantina di minuti delizia i presenti con un set emozionante soprattutto per chi è cresciuto a pane e Dinosauro sciorinando Thumb, Out There, Alone, Ocean in the way, Not You Again e addirittura Little Fury Things e The Wagon! Trovano spazio anche Drifter e Heal the Star, entrambe tratte dal secondo lavoro solista del 2014 “Tied to a Star”. Sulle note della mini sinfonia elettrica Geradewohl di Hans-Joachim Roedelius (Cluster e Harmonia) arriva il cambio di luci che annuncia il ritorno sul palco dei MBV dopo sette anni di assenza, ovvero da quando Robert Smith dei Cure, in veste di curatore dell’annuale Meltdown Festival, li invitò ad esibirsi nel 2018 al Royal Festival Hall.
Le rarefatte ondate di feedback introducono la febbrile e onirica I Only Said e quando parte l’intensa euforia disorientante di When You Sleep l’emozione diviene incontrollabile e gli occhi si fanno lucidi, pura magia che continuerà per tutta la serata in forma cangiante, ora trasognante pop (New You) dai tratti danzerecci (Only Tomorrow) addobbata in vestigie jingle jangle saturi di mieloso fuzz (Honey Power and Off Your Face) angelicamente fragile e delicata nonostante i leggendari volumi esagerati (Cigarette in Bed, Come in Alone) e da iperaccelerazione tachicardica (You never should). Sullo sfondo scorrono dilatate e distorte immagini psichedeliche, incessanti onde di luci stroboscopiche di colorazione rosa e viola ci avvolgono come fitta nebbia e ci perdiamo nel flusso sonoro tra gli intrecci delle corde vocali di sensualità androgina di Belinda e Kevin e gli intrecci ipnotici e miracolosi delle corde delle chitarre (che in alcuni pezzi diventano ben tre con l’aggiunta della fida Jen Macro), il tutto governato dalla precisione metronomica e dalla forza tellurica della sezione ritmica sapientemente guidata dalla guerriera Debbie e dall'inarrestabile Colm alla batteria. Il delirio estatico arriva con Only Shallow e continua con Nothing Much to Lose con la sequela mitragliatrice di Colm che scuote la gabbia toracica e l’oceano di feedback finale che ci seppellisce. Quando parte To Here Knows When, con la voce sussurrata di Belinda e la chitarra vorticosa di Kevin, perdiamo ogni concetto di gravità e finiamo chiusi in una soffice ed eterea bolla che ci trasporta in celestiali paradisi extracorporei. Ci stanno pure le vecchie Thorn, che suona come una versione inglese dei Dinosaur JR, e Slow, dal testo sconcio e il ritmo indie psych-danzabile che riscalda i muscoli per l’arrivo del pattern di batteria loopata dell’immarcescibile pietra miliare Soon, che dopo quattro decenni suona (e suonerà sempre) fantastica e che fa letteralmente esplodere in area il palazzetto col fragoroso ritmo dance della sezione ritmica, voce ultraterrena e chitarra che squarcia il groove con l’abrasività di un riff iterato che potrebbe continuare per l’eternità. Difficile proseguire dopo tanta grazia, per cui i nostri si giocano le uniche carte rimaste a loro disposizione, e sono assi pesanti che alzano ancora il tiro, per cui ecco in tutta la loro esplosiva furia l’assalto supersonico del furibondo dittico Feed Me With Your Kiss e You Made Me Realise, questa in versione allungata a dodici minuti con intermezzo di sei di puro rumore bianco obliterante che congeda i dodicimila presenti lasciandoli sì con qualche decibel di udito in meno ma anche la certezza di aver assistito a due orette scarse di imponente oblio sonoro, possente e magnifico. Ferruccio Guglia
Lino Capra Vaccina & MAI MAI MAI + Sanam
Monk, Roma, 24 novembre 2025
Il lunedì molto piovoso della capitale non trattiene un folto ed eterogeneo pubblico dal raggiungere il Monk al Portonaccio per assistere a una serata di musica dalle sfumature illuministe proposte attraverso una mescolanza di culture e tradizioni assai più lontane geograficamente che non dal punto di vista umano e quindi antropologico. In divenire, il sentiero unico e allegorico tradotto in una suite dai confini appena percettibili dei quattro componimenti de “I racconti di Aretusa” – ovvero la prima pubblicazione a catalogo della Baccano Dischi, la costola discografica della Luiss University Press, che collabora alla serata – è quello per il quale il percussionista e compositore Lino Capra Vaccina e MAI MAI MAI (Antonio Tricoli) aspirano a un coinvolgimento in relazione alla genesi dell’opera stessa, giunta a compimento delle due settimane di residenza che gli artisti hanno condiviso a Siracusa tre anni or sono, durante l’Ortigia Sound System Festival. Se Aretusa infatti è una fonte d’acqua dolce che sgorga nell’isola siracusana a poca distanza dal mare, e che secondo la mitologia greca deve il suo nome alla ninfa trasformata in sorgente da Artemide perché stanca delle continue attenzioni di Alfeo, le musiche di Capra Vaccina e MAI MAI MAI assecondano quella stessa narrazione amplificandone l’emotività con note di piano che, ripetendosi ciclicamente lungo tutta la trama, sembrano evocare la sofferenza di uno stallo esistenziale in contrapposizione alla moltitudine delle sollecitazioni positive della vita, metaforicamente rappresentate dalle fonti percussive sul tappeto dei variegati suoni sintetici che amalgamano tutto. Il legame empirico tra la leggenda di Aretusa e i due artisti, e tra gli stessi due artisti così distanti per età ed esperienze vissute, si traduce in un concorso di idee così ricco di significati che ogni singolo dettaglio sonoro, voci di popolo comprese, ci racconta noi stessi nell’animo più di mille inutili parole. E condividere questa esperienza dal vivo, al netto di ogni distrazione posticcia dalla trama che ha originato il progetto, è stato salutare, quasi commovente. Poi per proprietà transitiva (ammessa e non concessa, va da sé) ci si attendeva la stessa efficacia anche dai Saman ma, per quanto tanta fosse la curiosità all’inizio, una certa delusione alla fine la si è dovuta constatare. Ché trasferire dal vivo la bellezza di un disco (il recente “Sametou Sawtan”) non è mai semplice per nessuno e questi sei ragazzi di Beirut, seppur con tutta la buona volontà e con le attenuanti del caso, sono sembrati veramente acerbi e soprattutto, a prescindere dalle peculiarità che su disco emergono in modo più funzionale e caratteristico come il cantato in arabo e l’uso sistematico di uno strumento come il bouzouki, hanno dato l’impressione di essere ancora lontani da una loro precisa identità, non tanto per poterli collocare all’interno di un contesto definito quale che sia, quanto piuttosto che li possa rendere immuni da certi fastidiosi cliché quali ad esempio l’uso (seppur misurato) dell’autotune, di cui francamente non si sentiva il bisogno e non si sono avvertiti i benefici. Andrea Amadasi
Jethro Tull
Roma, Auditorium Parco della Musica, 24 novembre 2025
Onestamente credevo saremmo stati relativamente pochi al concerto dei Jethro Tull e, invece, sorpresa: sala piena e tanti giovani a dispetto di chi crede che questo sia un gruppo di culto per persone di una certa età. Il chitarrista Martin Barre, per decenni al fianco di Ian Anderson, è fuori da tempo, con grande strascico di polemiche, ma il leader ha messo su da qualche anno una nuova e stabile formazione (basso, batteria, tastiere e chitarra) e continua dritto per la sua strada, sebbene la voce e l’incredibile presenza scenica di una volta non possano più essere le stesse, avendo ormai quasi ottanta anni…
Concerto bellissimo, bisogna dirlo subito, grazie all’intelligenza di Anderson che sfugge alla trappola di presentare soprattutto i brani degli ultimi album e propone una sorta di “storia” dei Jethro Tull, a cominciare dal blues delle origini per arrivare alle ibridazioni con l’hard rock, il folk inglese, le suggestioni classicheggianti e rinascimentali che hanno creato l’unicità del sound della sua premiata ditta. Resta fuori solo il periodo “elettronico” quando, negli anni ’80, si incaponì a misurarsi con una dimensione che non era la sua, producendo scarsi risultati, fatto salvo quel capolavoro che è The Broadsword and the Beast (1982) dal quale, purtroppo, non è stato estratto alcun brano. Dopo un serioso avviso dagli altoparlanti (“il signor Anderson chiede gentilmente di non fotografare e registrare perché la sua musica è molto complessa da eseguire e i musicisti potrebbero distrarsi con i flash. Lascerà, però, che lo si possa fare durante il bis”), si parte dunque con Some Day the Sun Won’t Shine for You, dal primo album, This Was del 1968, dove colui che è passato alla storia soltanto come flautista si cimenta con l’armonica a bocca, suonata in maniera notevolissima (prego, cercare questo brano su YouTube in versione dal vivo, per verificare) e si prosegue con A Song for Jeffrey, introdotta dal vecchio amico e storico bassista della band, Jeffrey Hammond (sugli album sempre annotato come “Jefrrey Hammond-Hammond”), che si dichiara grato di esserne il dedicatario.
Ecco, una delle novità dei Tull 2.0 è l’uso intensivo dei video, impensabile nei concerti del periodo d’oro del gruppo, fatti solo di corpi, acrobazie e sudore. Un grande schermo alle spalle dei musicisti propone, infatti, immagini complementari ai brani eseguiti: frammenti di vecchi concerti (con Anderson capellone e magro), immagini della campagna e della vita operaia inglese per The Donkey and the Drum (i Tull sono stati uno dei gruppi più profondamente “British” della storia del rock), di barboni (per Aqualung) o semplicemente evocative, a commento del testo delle canzoni (fanno capolino anche le sagome di Freud e Jung, in relazione a Curious Ruminant, dall’ultimo album del 2025). Evitando la prevedibile scaletta cronologica, il gruppo salta direttamente a Thick As A Brick (1972), la lunga suite dalla quale viene proposto un breve estratto, e da allora si va avanti e indietro, percorrendo e ripercorrendo la lunga vicenda artistica dei Tull con Mother Goose e My God, da Aqualung del 1971 (precisissimo Anderson negli arpeggi, come già in Thick As A Brick, perché, ricordiamolo, è stato, ed è, anche un ottimo chitarrista acustico…), The Weathercock e i cori di Songs from the Wood (1977), entrambe dall’omonimo album del 1977 che aprì la cosiddetta “trilogia folk” (che comprende anche Heavy Horses del 1978 e Stormwatch del 1981), Aqualung, ovviamente, completamente rifatta in un arrangiamento che non è molto convincente, e Budapest, dall’album Crest of a Knave, del 1987, una canzone non particolarmente memorabile, molto influenzata dal sound dei Dire Straits (come tutto Crest, del resto), ma che, chissà perché, Anderson ritiene una delle sue migliori composizioni.
Resta da dire di Ian Anderson flautista, certamente ciò che più ha caratterizzato la sua attività musicale (ricordiamo che è stato anche un imprenditore, avendo gestito per anni un allevamento di salmoni in Scozia). Ebbene, la sua tecnica è decisamente più precisa e pulita, la diteggiatura accurata (alle origini se l’era completamente inventata lui, si mise a studiarla bene negli anni ’90, quando la figlia, che studiava il flauto a scuola, gli disse che era tutta sbagliata) ma certamente la potenza espressiva giovanile non c’è più, forse non può più esserci: quel l’uomo che ringhiava, sbuffava, eruttava in quello strumento, consegnandolo al linguaggio del rock dopo aver fatta propria la lezione jazzistica di Roland Kirk, è ormai un’altra persona e anche le oscenità che un tempo di divertiva a fare con lo strumento, e che divertivano le folle (compreso il sottoscritto) sono ormai consegnate alla storia e soltanto evocate qui e lì: resta un grande musicista che legge ormai il suo repertorio come un corpus unitario, divertendosi a ricombinarne le parti ogni volta in modo diverso. Non bisogna, però dimenticare, per finire, che anche i testi scritti da quest’uomo sono sempre stati di singolare originalità, talvolta autenticamente poetici, passando da piccoli spaccati della vita inglese di provincia, alla critica della religione istituzionalizzata, dalla satira dei tabloid popolari del Regno Unito alla celebrazione della vita rurale, fino alle riflessioni esistenziali di Minstrel in the Gallery, del 1976, agli appelli contro l’inquinamento e agli attacchi a Margareth Thatcher (proprio in Crest of a Knave). E, ancora oggi, Anderson è in grado di scrivere dei versi meditati, spesso linguisticamente molto ricchi, che purtroppo sono destinati a passare in secondo piano in un concerto rock come quello di ieri. Inevitabile il bis con il classico Locomotive Breath, preceduto da un video in cui, sempre lui, ci guarda da un binocolo (come sulla copertina di Stormwatch) e sulle lenti compare il via libera a usare i cellulari, per portarsi a casa un meritato ricordo. Giovanni Vacca
“Barezzi Festival”
Busseto, Parma, Fidenza, 13-16 novembre 2025
Passa in archivio anche la diciannovesima edizione del Barezzi Festival, sempre più itinerante per vocazione e ancor più versatile ed inclusivo nello spirito, poiché se la musica è il centro di gravità della tre giorni parmense è pur vero che intorno ad essa si fa largo l’idea di un mecenatismo romanticamente fuori dalla consuetudine, che si dilata in più direzioni con potenzialità tutte da esplorare. Con la rassegna parallela “Fuori rotta”, ad esempio, si è inteso proporre un percorso letterario alternativo attraverso incontri con docenti accademici, critici e storici dell’arte allo scopo di approfondire il rapporto tra arte e mecenatismo, con particolare attenzione alle contraddizioni che in esso possono celarsi, con l’esperienza vissuta e le figure di Giuseppe Verdi e Antonio Barezzi sullo sfondo a illuminare il pensiero critico. Ma poi anche arte figurativa con l’esposizione “Quadreria”, dipinti e illustrazioni che interpretano la musica in chiave contemporanea ad opera di artisti locali e non, quindi il contest Barezzi Lab, che ogni anno coinvolge decine di giovani musicisti che provano a definire il proprio percorso passando da una vetrina sicuramente molto stimolante. E infine “Barezzi Snug” per soddisfare anche il palato con la gastronomia delle osterie del centro storico di Parma, lasciandosi accompagnare nella degustazione dalla musica di artisti locali affermati. Questa è in sintesi l’esperienza immersiva che offre il Barezzi nei quattro giorni centrali del festival – perché tuttavia non è da dimenticare il Barezzi Way, ovvero l’anteprima che quest’anno ha visto il collettivo londinese Kokoroko rinverdire la sinergia col festival Aperto di Reggio Emilia, il 15 ottobre al teatro Valli, e Vinicio Capossela coi suoi “25 anni di canzoni a manovella”, quattro giorni dopo al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano – mentre poi ci sono i concerti veri e “pesanti”.
Si parte il 13 con i redivivi Mum al piccolo teatro di Busseto. Il collettivo islandese si è insinuato negli spazi spalancati dell’anima con la delicatezza di un decadentismo crepuscolare fatto di suoni ovattati e voci vellutate, al netto di misurate fibrillazioni che sporadicamente hanno enfatizzato una dimensione tendenzialmente acustica che non prevede roboanti colpi di scena, in una scaletta in perfetto equilibrio tra presente e passato. Venerdì e sabato ci si trasferisce al teatro Regio di Parma per le due doppiette combinate e ad aprire, alle 18.00 del venerdì, sono i King Hannah. Che ancora non hanno scelto se essere carne o essere pesce alimentando quel grande “boh” che evidentemente a loro non fa difetto, poiché se le canzoni ci sono ed è probabile che continueranno ad esserci, intorno ci si chiede se un compitino svolto in maniera così schematica e lineare sia il risvolto di una precisa volontà di apparire tanto algidi e distaccati o piuttosto l’effetto di un deficit di personalità che nel frattempo si è manifestato in tutta la sua evidenza. Per un’ora o poco più il palco del Regio è sembrato una prateria così sterminata che se Hannah Merrick e Craig Whittle sono riusciti a non perdersi è stato solo per il palpabile affetto del loro pubblico, che li adora a dispetto dei santi. Al contrario, dalle 21.00 quello stesso palco si è fatto capanna calda e accogliente in sospensione tra le luci soffuse e la musica di Tom Smith, venuto a Parma per presentare in esclusiva il suo primo album da solista, “There Is Nothing In The Dark Which Isn’t There In The Light”, in uscita ai primi di dicembre. Accompagnato da Nick Willes con chitarra e tastiera, a Smith basta davvero un nulla per creare quella morbida comunità d’animo col proprio pubblico, che ovviamente in larga parte è lì per lui come frontman degli Editors prima che per ogni altro motivo, e se questo lo si poteva immaginare, forse lui per primo non si aspettava un’accoglienza così calorosa. Di poche parole e con molta voglia di suonare, in chiave rigorosamente acustica, Smith assolve egregiamente al gravoso compito di rileggere alcuni dei pezzi più noti della sua band d’origine (Blood, Papillon e Munich le più applaudite), che in continuità col suo importante registro vocale si alternano ai pezzi del nuovo disco facendo un tutt’uno di confidenzialità e fragilità emotiva. Personalità da vendere ne ha pure Anja Franziska Plaschg, in arte Soap&Skin, che alle 18.00 del sabato si presenta sul palco del Regio con una The End dai toni lievi e minimali accompagnandosi col suo piano ibrido Feurich, per poi salire di registro in modo esponenziale cantando con temperamento ed eleganza in inglese, tedesco e italiano un repertorio che spazia trasversalmente dal classico al contemporaneo, evidenziando altresì una sorprendente versatilità nella scelta delle cover – oltre all’omaggio iniziale ai Doors, Me and Devil Blues di Robert Johnson, Mawal Jamar di Omar Souleyman, Gods and Monsters di Lana Del Rey e Pale Blue Eyes dei Velvet Underground – con le quali ha valorizzato d’enfasi la sua per certi versi già funambolica esibizione.
Alle 21.00 arriva finalmente il momento degli headliner dell’intera rassegna, ossia gli Spiritualized, che sul palco de “La prima estate” di Camaiore, a metà giugno, avevano risvegliato emozioni sopite da tempi antichi e lo stesso Jason Pierce aveva dato l’impressione di aver fatto pace con sé stesso e risolto le sue “vicissitudini” psico-fisiche. Cinque mesi dopo quelle stesse sensazioni accendono una luce più che lusinghiera in proiezione futura ma se un appunto sul concerto si volesse proprio fare, è solo quello di non aver osato con un surplus di pezzi del primissimo periodo per dilatarne ulteriormente la dimensione onirica, in un teatro anima e cuore tutto (esaurito) e solo per loro. I primi quindici minuti di Cop Shoot Cop avevano di molto alzato le aspettative e con Shine A Light, a stretto giro, si era già naviganti senza bussola; poi ad un certo punto si scorge il bagliore in un lontanissimo riverbero degli Spacemen 3 (Take Me To The Other Side) e in tutta onestà quello poteva anche essere l’approdo definitivo, ché la pace del cuore per una sera poteva dirsi raggiunta. Per la serata finale del festival si torna in provincia, nel piccolo e meraviglioso teatro di Fidenza, per il concerto di Micah P. Hinson, un personaggio tra le cui certezze acquisite, oltre le divertenti narrazioni del suo vissuto da texano adottivo, la sempre abbondante sudorazione durante i concerti e la capigliatura da mohicano nascosta sotto il cappello a tesa larga, c’è anche il sodalizio artistico con Alessandro “Asso” Stefana alle chitarre e alla tastiera e Paolo Mongardi alla batteria. Anche se leggermente imbolsito rispetto al Barezzi di due anni fa, Hinson rimane garante di sé stesso e della sua beffarda leggerezza, malcelata da una voce a cui non ci si abitua mai del tutto. Aveva un disco nuovo di zecca da cantare (“The Tomorrow Man”) e in un’ora e mezza non ha lesinato nulla, gigioneggiando con la sua chitarra ad altezza delle spalle, esternando con passione la sua premura per il popolo palestinese e infine chiudendo con un grande classico, The Same Old Shit. Anche per dire che la serata di fitta pioggia autunnale là fuori, alla fine, non è nemmeno tra le cose peggiori che ci possano capitare. Andrea Amadasi
The Schizophonics
Hootananny, London, 12 novembre 2025
Qualcuno dice che i californiani Shizophonics da San Diego sono una delle migliori rock’n’roll live band attuali, per cui mi dirigo a Brixton per constatare la veridicità di tale convinzione. Gli apripista Top Left Club, quartetto di Brighton, convincono col loro energetico set di synth-punk dai ritmi serrati - tra Stranglers e Ramones - e inaspettatamente entusiasmano quando, col bassista al microfono, si d-evolvono in una versione post Brexit piacevolmente tamarra del quartetto di Akron (aiutati dalle tute multicolorate indossate e da una bella presenza scenica teatrale). I coniugi Beers (Lety alla batteria) e Pat (voce e chitarra) approvano in pieno divertendosi come ragazzini mentre ballano con noi sotto il palco. Poi tocca a loro. Pat, pacato e quasi timido durante la nostra chiacchierata pre concerto, parte col primo riff che immediatamente innesta il processo di trasformazione che lo tramuta in un irresistibile ed esuberante frontman tra incontrollabili salti, vertiginosi volteggi, pericolose piroette, genuflessioni e contorsioni, giravolte da capogiro e capriole da circo equestre che continueranno per l’intera serata, il tutto mentre imbraccia la chitarra che viene suonata per la maggior parte sempre e solo con la mano sinistra, dato che la destra è impegnata a maltrattare l’asta del microfono che volteggia pericolosamente nell’etere. Con Pat zuppo di sudore dopo solo il brano di apertura (!) partono le selvagge Steely Eyed Lady e Streets of Heaven and Hell, che azzerano ogni nozione spaziotemporale trasportandoci nell'infuocata Detroit degli MC5. Non mancano i momenti di evangelizzazione alla Ian Svenonius, per cui ecco Pat che, da buon predicatore, prima incita il pubblico col singalong, poi invita a duettare chi ha il fegato di stargli dietro e infine si scaraventa direttamente sotto il palco continuando i suoi frenetici esercizi ginnici per ben due canzoni battezzandoci copiosamente con raffiche di sudore strizzato via grazie ai rapidi movimenti rotatori da trottola impazzita. Lo show, imprevedibile e caotico, è sempre sull’orlo del collasso, cosa che miracolosamente non avviene grazie alla sezione ritmica che tiene tutto insieme sulla via di Lety, novella Moe Tucker anfetaminizzata e di basso potente dell’amica Sarah Linton delle garage rockers Death Valley Girls. Tra gli originali trova spazio la cover Shake Baby Shake di Jack Dupree che forse però è A Whole Lotta Shakin Going On (non lo sapremo mai, dato che non c’è traccia di setlist sul palco) e Riff Raff degli AC/DC, che conclude la serata confermando che Pat, figlioccio bastardo di Little Richard, James Brown ed dello Ian sopracitato, è un ossesso, appestato dal verbo del fuoco sacro del rock, vittima sacrificale e carnefice: gli Shizophonics sono veramente una delle migliori rock’n’roll live band attuali. Ferruccio Guglia
Širom
RichMix, Londra,15 novembre 2025
La lungimirante programmazione del sempre attento promoter londinese Baba Yaga ci offre la prima data europea del terzetto sloveno Širom, ovvero quanto di meglio l’universo avant folk possa attualmente offrire. Peccato che gli irlandesi Rún, che avrebbero dovuto aprire la serata, siano impossibilitati ad esibirsi a causa di un infortunio alla cantante: la sostituta, una ragazzina del Lancashire che si presenta col nome d’arte Thorn Wych, ci ammalia per una trentina di minuti con un mantra dronico che si erge sulle corde pizzicate dello strumento autocostruito da un ramo di olmo montano (“wych elm” in inglese, da cui l’alias da lei scelto) mandato in loop su cui improvvisa con flauti e corde varie salmodiando canti devozionali in una lingua misteriosa e sconosciuta, il tutto filtrato attraverso pedali in delay e pitch bending (manovrati con le dita dei piedi) che aumentano esponenzialmente la singolarità della proposta.
Dopodiché, facendo bene attenzione alla miriade di strumenti e oggetti dislocati sul palco, il trio sloveno entra in scena. Samo accarezza l’arpa, i delicati tocchi del balafon di Ana invitano le tre corde basse del guembri di Iztok e parte Between the Fingers the Drops of Tomorrow Dawns, un viaggio di 17 minuti di misteriosa arcana bellezza con la ritmica del tamburo a cornice di Samo a scandire il ritmo. Le struggenti corde del banjo sfregate con l’archetto da Iztok si intersecano con quelle toccanti del liuto di Samo e preannunciano l’accecante delirio estatico raggiunto grazie ai vocalizzi di Ana. I gorgheggi continueranno nella successiva Tiny Dewdrop Explosions Crackling Delightfully con iniziali ritmiche gamelan ed intenso crescendo delle corde di Ana (il ribab prima e il violino dopo), il banjo di Itzok e la lira di Samo che aggiunge un ulteriore strato di straniante fascino grazie ai vertiginosi vortici ciclici dell’hurdy-gurdy con Ana, impegnata a emettere una sequela di timbriche percuotendo una miriade di tegami, casseruole, pentole e paioli di varie dimensioni. La serata si conclude con i trenta minuti del medley Curls Upon the Neck… e The Hangman’s Shadow Fifteen Years On, con inizio da musica classica, quasi liturgica, e progressiva, inesorabile esplosione ritmica con le basse corde di Samo accompagnate dalle tormentate grida che sembrano riecheggiare le urla di tutte le popolazioni afflitte e perseguitate di questo pianeta in un intenso crescendo che le tramuta un una voce sola, dolorosa e sofferta: quello della stessa terra stremata, violentata e umiliata dalla crudele stupidità umana. Il finale percussivo suona come l’auspicio di un agognato ribelle riassetto tellurico necessario per motivi di mera sopravvivenza ma forse, più prosaicamente, è la mera rappresentazione sonora del rovinoso sfacelo attuale. L’unica certezza è che in questa triste epoca di pericolosi nazionalismi, brutali divisioni e intolleranze, lo splendore atavico e la magnificenza arcana dei Širom è necessaria, indispensabile, obbligatoria. Ferruccio Guglia
Le Guess Who?
Utrecht, diverse location, 6-9 novembre 2025
Un’altra narrazione, un punto di vista più intrigante e colorato. Scomponiamo i fattori e partiamo da un episodio. Bordo palco, ingrandimento, siamo quasi al termine della performance degli [Ahmed] – collettivo internazionale con base a Londra e guidato spiritualmente dal pianista Pat Thomas – senza ombra di dubbio una delle più intense dell’intero festival. Vedo un paio di loschi figuri che si agitano, si dimenano, uno di loro addirittura incita Pat con il pugno chiuso, in una trance emotiva che travalica addirittura il ‘concerto rock’, calandoci idealmente nelle spire del tifo da stadio. È Greg Anderson, che, con il fido Stephen O’ Malley al fianco, appena terminata la performance dei Sunn O))) si precipitano ad ascoltare una delle realtà più sfuggenti di tutto il tribolato universo free jazz contemporaneo. Suonano alla velocità della luce gli [Ahmed], un quartetto che prende il radicalismo della musica libera e lo sovverte inseguendo nuovi modi d’uso. Un dizionario fatto di strappi, micro-fratture, frammenti infinitesimali che si susseguono impunemente rimettendo in scena l’atto sacrificale che un tempo fu dei migliori combo apparsi sotto la gloriosa sigla ESP Disk. Ma non pensate ad un’opera di restaurazione, l’urgenza metropolitana del loro suono è un unguento, una curativa forma di intrattenimento alto nelle maglie del grigiore urbano. L’episodio ci aiuta comunque a capire quanto sia autentico lo spirito ‘comunitario’ del festival, coi suoi curatori, coi musicisti che collaborano a più riprese occupando diversi spazi, rispondendo ad una necessità artistica incontaminata. Alle soglie del ventesimo anniversario che si consumerà l’anno venturo Le Guess Who? conferma la totale demolizione degli steccati indie con cui aveva in qualche misura avuto a che fare nei primi anni di esistenza. La manifestazione è transglobale, con protagonisti provenienti anche dai più remoti angoli dei cinque continenti.
Una delle tante vette performative del festival – il gusto personale orienta immancabilmente le scelte– è nel gioioso e animato live del trio afro-americano di Portland Cosmic Tones Research Trio. Investiti da due ottime pubblicazioni per Mississippi, i nostri già nella sigla rimandano alle nobili intenzioni dell’Arkestra, puntando però ad un approccio che rivela inedite soluzioni cameristiche. Sassofono, violoncello e piano mutano linguaggi jazz con una gentilezza che per assurdo potrebbe essere quella della Penguin Cafè Orchestra precipitata nell’universo black. Più massimalista in questo senso l’approccio del gruppo guidato dal batterista sud-africano Asher Gamedze (with A Semblance), una musicalità che nasce dalla grande tradizione degli esiliati inglesi (gli originali Blue Notes) per connettersi agli universi di hip-hop, downtempo e improvvisativa. Una lezione di storia si concretizza invece nelle parole e letture del campione di slam poetry Saul Williams, oggi intellettuale ‘lisergico’ che attacca con una sentita reprimenda per i coloni olandesi. Sull’onda della fondazione di New Amsterdam e dei commerci sregolati della Dutch East India Company, un testo fiume musicato da Carlos Nino alle percussioni e Surya Botofasina al piano elettrico ed acustico. Spoken ambient-jazz che attraversa le dolorose maglie del nostro tempo, un percorso di autocoscienza che rimette al centro l’individuo tartassato dai conflitti e dalle contraddizioni dei tempi moderni. Un appello ancora più sinistro in un momento in cui il confronto sui ‘territori’ è lungi dall’esaurirsi. Perché questo festival è politico, centrato, avverso a ogni forma di offesa e sentire guerrafondaio. Una delle curatrici di questo festival è Valentina Magaletti, che ho avuto il piacere di osservare in coppia con Upsammy in un mirabolante dialogo organico tra batteria, percussioni ed elettroniche manipolate in tempo reale. Più diretto e contaminato con la club culture l’altro progetto V/Z, condiviso con il bassista dei Vanishing Twin e storico producer elettronico Zongamin. L’astrazione è invece di rito nell’incontro tra Nicholas Jaar e il vocalist pakistano Ali Sethi, dove i linguaggi della tradizione sufi e dell’elettronica più minimalista trovano un terreno fertile in cui avvicendarsi. La storia viene spesso rivista e corretta in questi ambiti così spugnosi e capienti. C’è il ritorno delle leggende reggae Congos, da cui mi smarco senza rimorsi, mentre non resisto alla rinnovata veste dei Pram, architetti sonori che tanto fecero nel circuito del cosiddetto post-rock inglese. La loro notturna poetica wave-cabarettistica non perde un’oncia dell’originale afflato, trasportandoci di nuovo in sibilline stanze segrete. Citazione d’onore anche per i libanesi Ghadr, in pratica un offshoot dei Sanam in chiave decisamente post-industrial, e l’onorato meeting tra il produttore Al Wootton e la vocalist e musicologa - anch’essa libanese - Youmna Saba. Per quattro giorni il mondo si incontra idealmente nelle ariose sale dell’auditorium Tivoli, dei club circostanti e delle chiese messe gentilmente a disposizione dalla giunta locale. Un miracolo, non riesco a trovare altro termine. Luca Collepiccolo
Rob Mazurek / “This Ever Existence Flare”
Reggio Emilia, Teatro Ariosto, 8 novembre 2025
Il trombettista e compositore Rob Mazurek, musicista fra i più operosi e apprezzati della scena che si può genericamente definire avant-jazz, è anche pittore che considera la pittura come un’estensione della musica: ogni suo quadro è una “partitura visiva” caratterizzata da forme astratte, colori intensi e segni gestuali, che richiamano l’energia dell’improvvisazione nel jazz. Come già diverse volte in passato in sue performance multimediali, anche in “This Ever Existence Flare”, opera “totale”coprodotta da AngelicA e dalla Fondazione I Teatri e rappresentata a Reggio Emilia al Teatro Ariosto in prima mondiale, ha fatto dialogare le immagini delle sue pitture (digitalizzate in video manovrati caleidoscopicamente da Mathieu Constans) con la musica, con una voce recitante e con canti singoli e corali, creando un’esperienza multisensoriale potente e sofisticata di grande impatto visivo e scenico. Il testo del libretto, pure esso scritto da Mazurek ispirandosi a “Book Of Sound” di Damon Locks che, sotto lo pseudonimo immaginario di Helder Velasquez Smith, nella formazione è la voce narrante, intreccia fantascienza, filosofia e visioni poetiche in una narrazione che si sviluppa in tre atti con flusso continuo senza intervalli.
Il gruppo, denominato significativamente “Immortal Birds Bright Wings”, è formato, oltre che da Mazurek alla tromba e al citato Damon Locks voce recitante, alle elettroniche e alla danza, da Fabrizio Puglisi al pianoforte (pure assistente musicale in fase di messa a punto durante le prove), Koun Jeong al gayageum e al piano elettrico, Pasquale Mirra al vibrafono, Danilo Gallo al contrabbasso e al basso elettrico, Mauricio Takara alle percussioni e percussioni elettroniche, Cristiano Calcagnile alla batteria e un coro di quattro voci: Rachele Amore, Silvia Fiume, Elisa Giovanditti e Alessandra Franchina. Proprio il coro è stato il fulcro musicale dell’intera architettura, assumendo l’importanza che aveva nel teatro greco, quindi pure introducendo e commentando gli eventi, fornendo informazioni di contesto e anticipando sviluppi. Stilisticamente, sempre mescolandosi con gli strumenti e la voce narrante, questo coro s’è avvicinato al gospel e ai canti di lavoro, all’uso potente che ne ha fatto Max Roach in “It’s Time”, ai duetti emozionanti in “West Side Story” di Leonard Bernstein, genericamente al canto jazz e folk, anche con momenti avvincenti di rimescolamento turbolento (un plauso alle bravissime giovani coriste, intonate, ben amalgamate, espressive, scese perfettamente nella parte).
La musica strumentale, sia quando s’è mescolata al coro o ha commentato e sostenuto la voce narrante, sia quando s’è presentata autonomamente, ha formato quadri a sé stanti di differenti impostazioni, dai più chiassosi e concitati a quelli più pacati. È stata perfettamente ingabbiata da Mazurek in strutture precise, ma dando sempre un’idea concreta di libertà, dove alle parti scritte si si sono aggiunte, mantenendosi sulla stessa lunghezza d’onda espressiva, quelle improvvisate, spesso arrivando a momenti simil-free, con l’instancabile superbo vibrafono di Mirra protagonista, Puglisi a sottolineare la bellezza della scrittura, Koun Jeong a dare afflato orientaleggiante con il gayageum, Gallo, Takara e Calcagnile a supportare ritmicamente con fantasia ed estro e concretizzando qualche episodio africaneggiante con una fitta poliritmia, infine il leader che s’è limitato a quattro non lunghi interventi solistici, ma ogni volta conferendo ancor più incisività al contesto attraverso il suo teso, spezzato e discontinuo fraseggio con cui alterna note acute e penetranti con suoni gravi e distorti. Aldo Gianolio
“Festival dei Popoli” 66a ed.
Firenze, 1-9 novembre 2025
La 66ma edizione del Festival dei Popoli sono stati presentati due documentari ispirati a Firenze e alla musica rock fiorentina. Il primo, “Piero Pelù. Rumore dentro”, già proposto fuori concorso alla 82ma. Mostra di Venezia, è un film di Francesco Fei, regista fiorentino, autore di video musicali e documentari o docufiction su artisti, e di Piero Pelù, che ha contribuito al soggetto e alla sceneggiatura. Il film descrive come un diario l’incidente verificatosi nel 2022 e il percorso di recupero. Un cambio di cuffie in sala di registrazione ha provocato uno svenimento e un danno al nervo acustico, un acufene, un ronzio permanente non legato a sorgenti sonore. Questo ha costretto Piero ad interrompere tour programmati e a stare per un po' lontano dal palco. È un problema - come ha detto Piero nel dibattito seguito alla proiezione - di cui soffrono molte persone: il 10-15% della popolazione adulta mondiale e, solo in Italia, più di 6 milioni. Problemi di udito ebbe Beethoven, che rimase sordo progressivamente a partire dall’età di 30 anni, eppure compose opere straordinarie in seguito. Nel rock o il pop, in cui la esposizione a volumi sonori elevati è frequente, di acufeni o ipoacusie hanno sofferto o soffrono molti musicisti, fra cui Eric Clapton, Phil Collins, Sting, Brian Johnson (AC/DC), Dave Grohl, Lars Ulrich (Metallica), Antony Keidis (Red Hot Chili Peppers), la buonanima Ozzy Osbourne (Black Sabbath) e pure Neil Young, Pete Townshend, Chris Martin (Coldplay) e Noel Gallagher. Questo fastidioso ospite che Piero si porta da allora dentro è diventato uno stimolo per una immersione nel mondo interiore e per una successiva ripartenza in chiave di viaggio, di cui il film mostra il toccante svolgimento. Un percorso on the road e off road, in cui la musica accompagna il protagonista. Piero ci mostra questa evoluzione sofferta ma orgogliosa utilizzando frammenti del suo sconfinato archivio video. Si avvicendano sullo schermo i compagni di avventura, gli amici a partire dai Litfiba. Il viaggio ha echi spirituali insospettabili, con il pellegrinaggio a Saintes-Maries-de-la-Mer, in Camargue, per Santa Sarah la Nera, santa laica non riconosciuta dal calendario e protettrice di gitani, viaggiatori e migranti, il cui nome Piero si è fatto tatuare. Dalla dimensione autobiografica riemerge con determinazione la voglia di esserci e andare avanti, con la musica e per la musica, con il consueto stile schietto, libero e irriducibile e con la coerenza che sempre in lui abbiamo ammirato. Piero è artista inossidabile e resiliente, sempre sensibile alle battaglie alte, alle questioni sociali e, come dimostra il caso della vertenza GKN, ai problemi drammatici del mercato del lavoro.
Il secondo docufilm è "Uscivamo molto la notte" di Stefano Pistolini, giornalista, scrittore e regista, col contributo di Bruno Casini, brillante animatore della stagione irripetibile che va dal ‘79 ai primi anni ‘80, in cui Firenze, in uno dei suoi tanti "rinascimenti", diventò sede di un movimento vivace ed emozionante della cultura giovanile, attirando per il suo dinamismo folle e figure intellettuali dal resto dell'Italia e dall'estero, fra cui Pier Vittorio Tondelli. Una stagione di creatività, una tendenza al divertimento appassionato e alla creazione di locali di culto spesso ricavati in spazi angusti o di fortuna. Sono stati protagonisti una moltitudine di club leggendari come Banana Moon, Manila, Tenax, Casablanca, Rockoteca Brighton, Nel film, impostato come flusso di immagini e ricordi, compaiono i personaggi che hanno contraddistinto quella epoca: Piero Pelù e i Litfiba, i Diaframma, i Neon, Sandro Lombardi dei Magazzini Criminali, Federico Fiumani e le immagini evocative di una esplosione di energia e di edonismo improvvisato ma vincente. Si parla di negozi di vinili come Contempo Records, diventato poi etichetta discografica. Oggi di dischi se ne vendono pochi ma i concerti si continuano a fare, recuperando o valorizzando alcuni siti periferici, anche se forse una organizzazione complessiva ed efficace degli spazi di aggregazione in città non c’è. La volontà di provare il nuovo, con un approccio artigianale e schietto in cui si mescolavano le nuove tendenze musicali con gli influssi che arrivavano dall'estero, soprattutto quello del punk e della new wave, la moda, la conversione in oggetti glamour dei tessuti poveri, in generale la valorizzazione delle idee, il teatro di avanguardia. Bruno suggerisce di trarre da quella stagione irripetibile spunti da riutilizzare nel presente e per il futuro: alcuni gruppi o musicisti dell'epoca sono ancora attivi e anche se nel complesso c'è stato uno smorzamento dell’attività rispetto a quella fiammata, lo spirito resta intatto dentro tutti noi. Giuseppe Barbagli
“Club2Club Festival”
OGR – Lingotto, Torino 30/10-02/11 2025
Questa è stata un’edizione speciale per chi da tempo frequenta il festival torinese: un viaggio ascensionale “per aspera ad astra” (come recita il motto di quest’anno), dedicato alla memoria del suo fondatore e direttore Sergio Ricciardone, scomparso l’anno scorso. La commozione era palpabile, la partecipazione copiosa ed entusiastica.
Il ritorno alle Officine Grandi Riparazioni di Torino per la serata di giovedì è stata una sorpresa gradita. Era attesissimo il set di Daviel Blumberg, l’ex-indie rocker fresco di premio BAFTA per la colonna sonora di “The Brutalist”: ma l’idea di impostare il live sui droni di viola e contrabbasso, sparsi samples elettro-acustici e melodie strozzate ha lasciato un po’ perplessi. Meglio gli YHWE Nailgun, a cui va tutta la nostra simpatia per il nome ge
TUTTLE Edizioni - P.iva 01637420512 - iscrizione rea n. 127533 del 14 Gennaio 2000